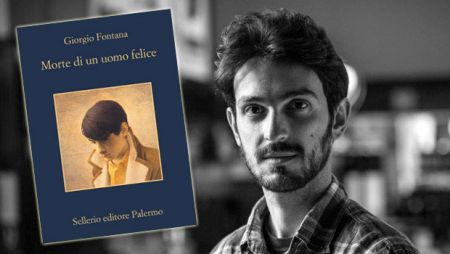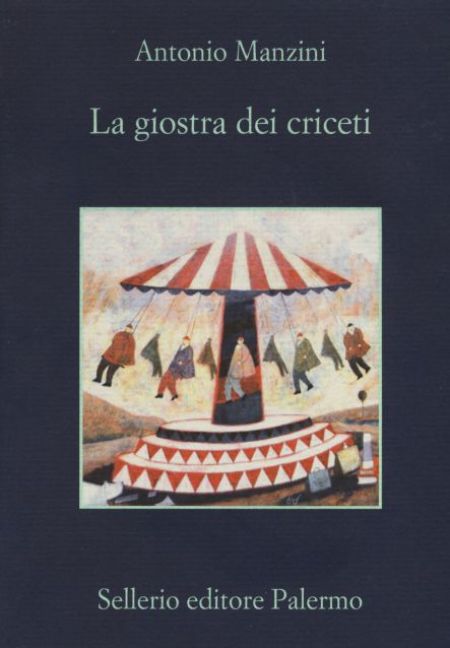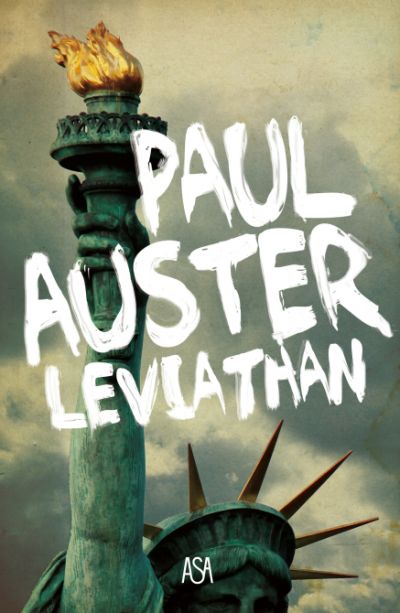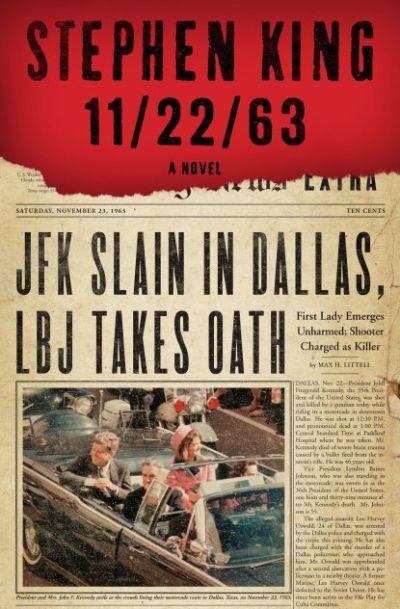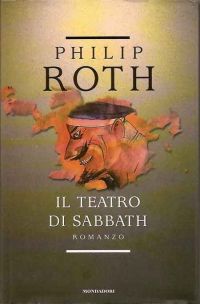La morte dell'avvocato Colajanni era costata 24 milioni di lire, tutti in banconote da centomila. Quando Davide Maestrelli - questo era il nome del killer - venne fermato dai carabinieri ad un posto di blocco nei pressi di Gioia Tauro, la borsa era ancora sul sedile anteriore. Maestrelli non oppose resistenza, ma confessò l'omicidio solo dopo un lungo e tormentato interrogatorio. In un primo momento, l'assassino riferì di non conoscere l'avvocato. Disse di avergli soltanto rubato l'auto, all'interno della quale aveva poi trovato, per puro caso, la borsa con il denaro. Una versione debole, poco verosimile. Nonostante tutto però Maestrelli riuscì ad evitare l'ergastolo. Abbandonò definitivamente il carcere di Opera nel novembre del 1999. Oggi credo lavori in una comunità di tossicodipendenti in provincia di Pisa. Agli inquirenti raccontò che fu contattato dall'avvocato tramite un suo cliente, tale Antonio Santomauro - il cui nome, per la verità, non mi dice nulla - e che Colajanni dovette faticare parecchio per convincerlo ad eseguire quell'incarico così speciale. Raccontò pure che la somma richiesta all'avvocato era di gran lunga inferiore a quella contenuta nella borsa: circa la metà. Colajanni dovette insistere affinché accettasse il doppio, perché la sua vita - avrebbe detto nel corso della trattativa - valeva molto di più dei quindici milioni di cui Maestrelli si sarebbe accontentato. In realtà Mimmo avrebbe preferito spararsi da solo. Ci provò una sera che eravamo andati tutti via dallo studio. Dopo aver fumato tre o quattro sigarette, si scolò un’intera bottiglia di Vodka. Tirò fuori dalla borsa la rivoltella che gli aveva procurato un suo vecchio conoscente, Gennaro Caravano - detto “pachialone” - se la puntò alla tempia, chiuse gli occhi, e premette il grilletto. Pensò di essere già morto quando si accorse che la sicura si era bloccata misteriosamente, impedendo così all'unico proiettile inserito nel caricatore di uscire dalla canna. Da allora non volle più riprovarci.
La sua uscita di scena l'avvocato volle curarla nei minimi dettagli. Intendo dire che non si limitò soltanto a scegliersi l'assassino e a pattuire con lui il prezzo del delitto, ma si premurò anche di programmare il futuro del suo studio legale attraverso una lunga lettera testamento che redasse in duplice copia. Una ce la fece trovare nel primo cassetto della scrivania, l'altra la consegnò al notaio Carmando di Torre Annunziata. Quella lettera, scritta di suo pugno e su carta intestata, era un vero capolavoro letterario, a metà strada tra una memoria difensiva e una sceneggiatura teatrale. Nessun altro documento, neppure fotografico, ha raccontato la personalità e la natura più intima di Mimmo Colajanni meglio di quelle poche righe. Per prima cosa, l'avvocato volle spiegare le ragioni del suo gesto, che a suo dire fu dettato dall'insostenibilità di una vita “troncata nella sua parte essenziale”, quella per cui diceva di essersi sempre battuto: ottenere la stima di chi lo aveva conosciuto e frequentato. La seconda parte del testo l'avvocato la dedicò invece ad ognuno dei suoi colleghi di studio. Tutti, compreso Brunella, l'ultima arrivata. Una sorta di pagellino nel quale si divertì a tracciare il profilo umano e professionale di ciascuno, evidenziando pregi e difetti come farebbe un maestro elementare con i suoi alunni. In cima a quell'elenco l'avvocato scrisse il nome della segretaria: Irene Monterisi. Mimmo la definì “una collaboratrice straordinaria, perno insostituibile dello studio e sua memoria storica. Confidente insuperabile e lavoratrice instancabile”. L'aveva conosciuta a Sorrento, nello studio del collega Pippo Marano. Mimmo rimase colpito dalla velocità con la quale quella ragazza magrolina e dalle mani affusolate riusciva a scrivere sotto dettatura, sia a macchina che a mano. E dai modi gentili che adoperava per ricevere ed intrattenere i clienti. Irene parlava correntemente l'inglese ed il francese, e se la cavava pure con il tedesco, essendo di madre berlinese. Dopo aver terminato le magistrali si iscrisse all'università. Ma alla fine del primo anno fu costretta ad abbandonare gli studi per mantenere i suoi fratelli, rimasti come lei orfani di entrambi i genitori. Per convincerla a lavorare nel suo studio, Mimmo le promise il triplo dello stipendio che le pagava l'avvocato Marano. In più, si offrì di pagare personalmente le spese mediche per le cure del fratello più piccolo, affetto da una malattia rara e poco conosciuta. Attenzioni che Irene meritò pienamente per le eccellenti doti organizzative che fecero di lei il vero dominus dello studio. Più che una segretaria, Irene era un avvocato aggiunto; aveva maturato un tale esperienza sul campo che, se solo avesse voluto, sarebbe stata in grado di gestire una causa da sola, dall'inizio alla fine, e di andare in aula a patrocinare. Nessuno se ne sarebbe accorto che non aveva studiato la legge.
Ben diverso fu il capitolo dedicato a Federico. Mimmo ne parlò come di “un ragazzo generoso e sensibile, prestato all'avvocatura (proprio così), ma sempre disponibile con chiunque avesse bisogno”. Federico era tra virgolette capitato nel suo studio per una promessa che l'avvocato aveva fatto a suo padre, Attilio, caro amico di infanzia e mancato collega. Più che l'adempimento di una promessa, l'assunzione di Federico Mimmo la definì un dovere morale. Dovere che però gli costò parecchio in termini di salute e di denaro. Lo stress nervoso che Mimmo accumulò per le sua bizzarra interpretazione della professione lo portò più di una volta a sfiorare l'infarto. Per colpa di Federico l'avvocato perse almeno tre cause facili facili, e fu costretto a risarcire di tasca sua numerosi clienti malcapitati. Effettivamente Gustavo, Maria, Federico De Cleva, fin dagli esordi, manifestò una scarsa inclinazione per la professione forense. E la sua sbadataggine in alcuni momenti rasentava la disabilità. Il lato forte del suo carattere era sicuramente la simpatia ed un innato senso dell'umorismo. Istintivo direi. Federico era capace di farti ridere nei momenti più impensabili anche con un semplice gesto, con la sola mimica facciale. Quando grazie ai suoi buoni uffici perdemmo la causa con una nota multinazionale americana, lui disse che lo aveva fatto apposta per non incrinare il patto atlantico. Solo una volta l'avvocato fu sul punto di mandarlo via sul serio, il giorno in cui smarrì un pacco di cambiali che lui raccontò di aver utilizzato come fiches per giocare a poker con gli amici.
Federico è stato per me come un fratello. Io e lui, insieme, abbiamo girato mezzo mondo divertendoci come matti. Non ci crederete ma una volta in Africa, nell'estate del '70, Federico mi salvò la vita. Davvero. Capitò durante un safari. Avevamo perso le coordinate del gruppo; cominciammo allora a seguire un sentiero che ci era stato indicato da un abitante del posto. Ad un tratto, mentre mie ero accovacciato per prendere una mappa dallo zaino, sentii alle mie spalle Federico fare un balzo. Mi voltai pensando che fosse inciampato o che volesse farmi uno dei suoi scherzi. Invece no: si era avventato su un pitone che stava per afferrarmi la caviglia. Estrassi immediatamente il coltello che mi ero portato dietro e glielo conficcai sulla testa. Al pitone. Dopo quella disavventura, la sera, al villaggio, gli organizzatori del safari ci festeggiarono come degli eroi e ci regalarono una nuova vacanza. Di quel pitone e della sua uccisione alla maniera di Indiana Jones ne parlarono tutti i giornali, anche qui in Italia. Federico fu addirittura ospitato in uno show televisivo e intervistato da un noto documentarista. Conservo ancora nel mio salotto la pelle viscida di quella bestia. Cinque anni dopo volli ricompensare Federico per il suo gesto eroico. Decisi di aiutarlo a ricomprare l'appartamento di via Foria che aveva perso in una sciagurata partita a poker, al casinò di Venezia. Una serata terribile. Con una misera doppia coppia di 10 il mio amico ebbe la brillante idea di aggiungere al piatto altri due milioni e mezzo di lire. Quando gli avversari scoprirono le carte, Fede rischiò il coma.
Brunella era stata una studentessa modello. Si era laureata a pieni voti, in tre anni e una sessione, con una tesi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio ( il divorzio). Mimmo nel suo pagellino la definì “degna di cotanto padre – Guido Masturso era stato presidente della Corte d'Appello di Firenze e autore di diverse pubblicazioni - e dotata di grande versatilità”. Indossava solo vestiti scuri, giacca e pantalone. Dava del lei a tutti e non amava intrattenersi a lungo con i colleghi. Anche perché il fidanzato, Gianluca, era gelosissimo. L'accompagnava tutte le mattine in studio e tornava a prenderla la sera, dopo le otto. Una volta Gianluca vide Brunella prendere un caffè con Federico, giù al bar di Tonino. Scherzavano. Federico, come al solito, faceva le imitazioni dei colleghi di studio. Gianluca attese che i due uscissero dal bar, e dopo aver allontanato la fidanzata con il braccio, sferrò un montante al viso di Fede stendendolo al suolo come una pera cotta. Da allora Federico evitò qualunque forma di contatto con Brunella. Anche in Tribunale. Anzi, ogni volta che lei gli si avvicinava, scappava con una scusa qualunque.
Per Giulia, “la figlia perduta”, Mimmo scrisse solo un mestissimo “omissis”.
Al sottoscritto, “il figlio maschio che non aveva mai avuto”, l'avvocato dedicò un profluvio di parole struggenti. Tra me e Mimmo c'era sicuramente un affetto speciale. Mimmo segui con molta dedizione il mio praticantato. E non solo quello. Era attento ad ogni dettaglio, anche nell'abbigliamento. Mi dava continuamente delle dritte sulla scelta delle giacche e delle cravatte. Mi voleva uguale a lui, e un po' ci riuscì. Amava scherzare e divertirsi, ma sul lavoro era intransigente. Molto. I primi mesi allo studio urlava in continuazione. Non ammetteva nessun errore. Tutto quello ho imparato lo devo a lui. Anzi, se devo dirla tutta, Mimmo mi ha insegnato anche quello che non ho mai saputo o capito della mia professione. La prima volta che andai in udienza da solo gli riferii che non seppi replicare a un'osservazione del giudice. Lui non trattenne la rabbia – Come sarebbe non hai detto niente? Un avvocato sa sempre cosa dire. Dovevi inventarti una cazzata qualunque. - Ecco, questo era Domenico Colajanni.
Un'ultima annotazione Mimmo volle riservarla agli altri colleghi del Foro di Napoli, a cominciare dal presidente dell'Ordine, Piero Corradi. - Caro Piero - questo l'incipit - è da molto tempo che volevo dirtelo: come avvocato non vali un cazzo, ma come uomo sei anche peggio. - Particolarmente significativo l'ultimo rigo - Vi diffido dal prendere in considerazione qualunque forma di commemorazione pubblica in mio onore all'interno del Palazzo di Giustizia. –
Così parlò il defunto Colajanni.
(Angelo Cennamo)